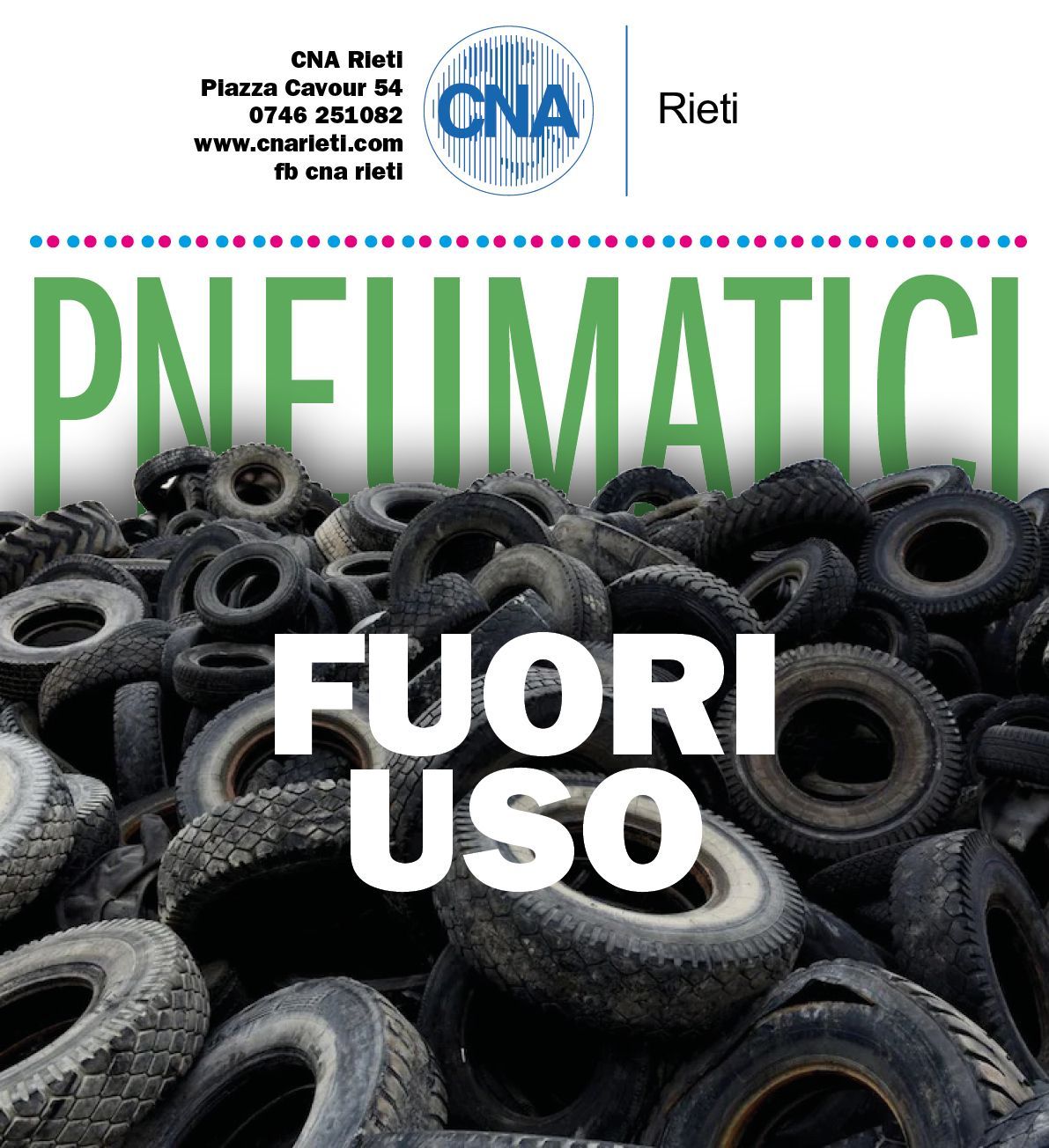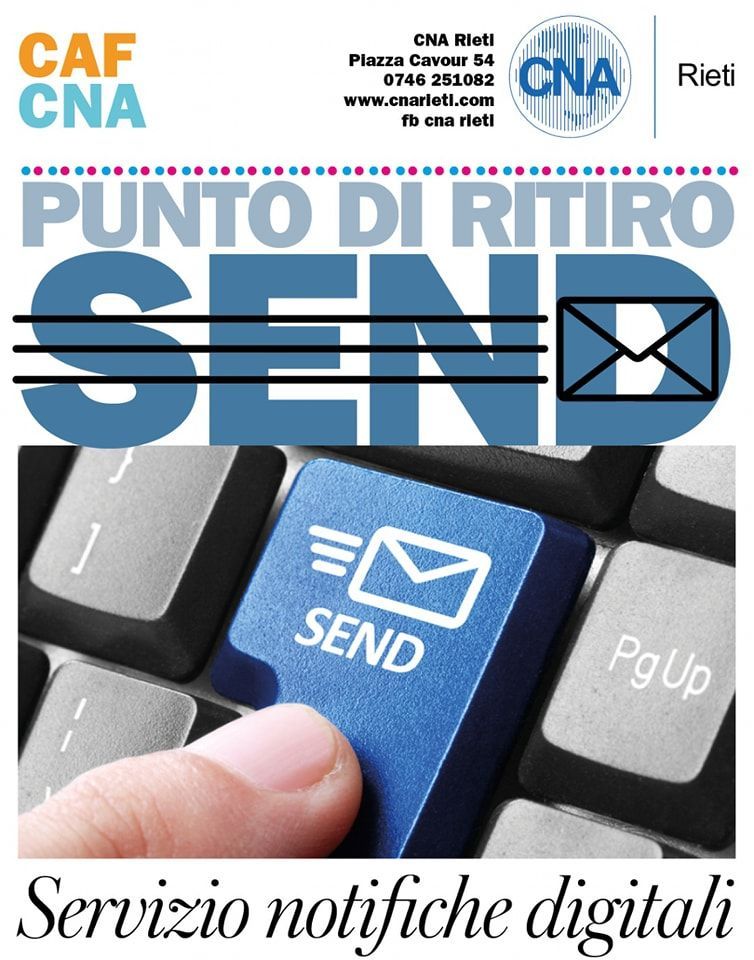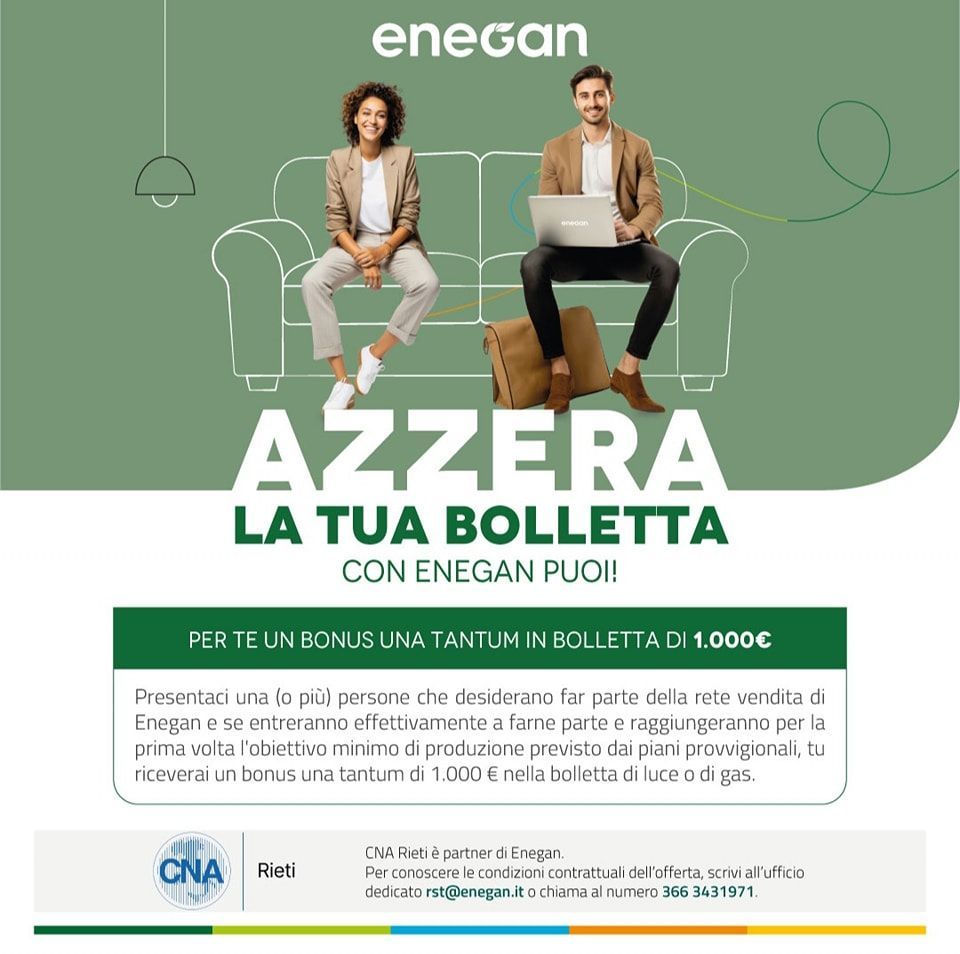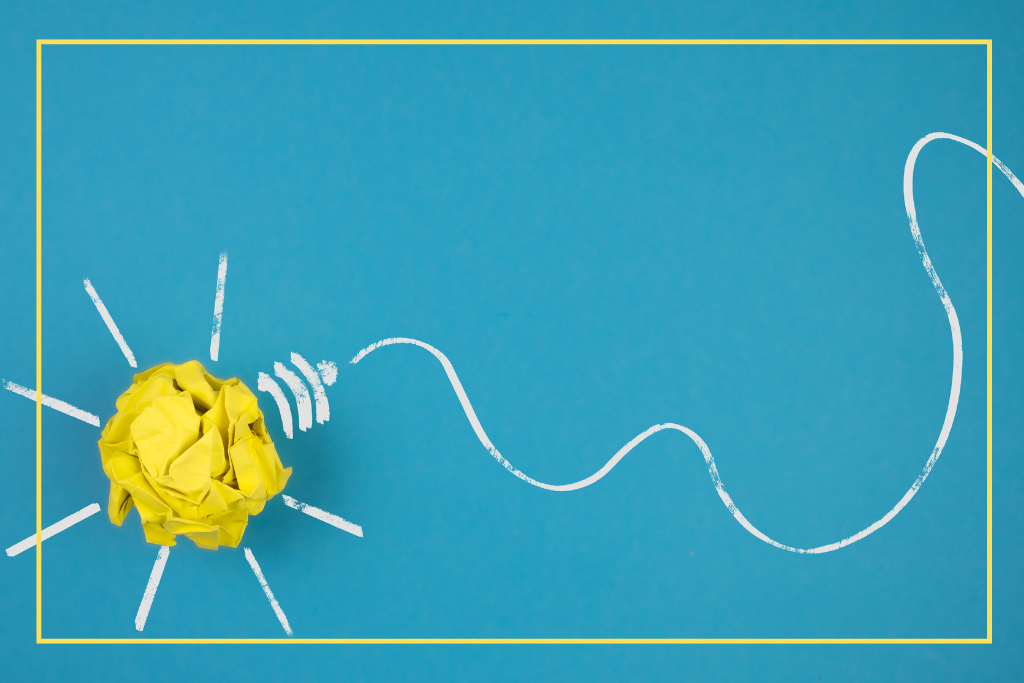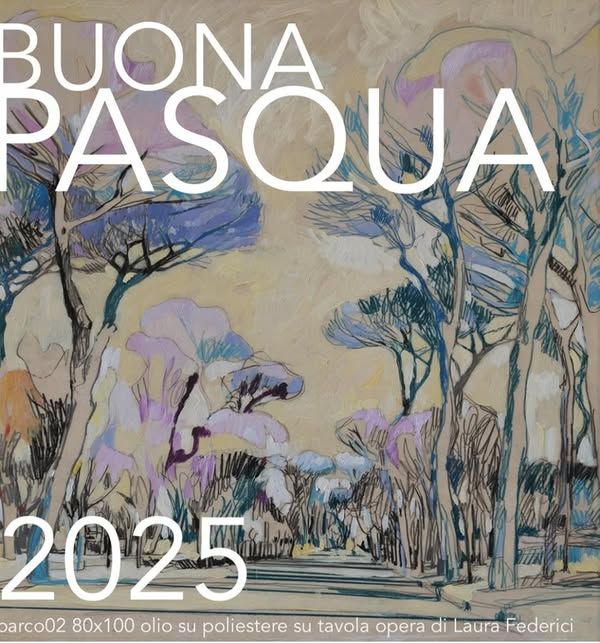PANDEMIA e QUESTIONI di GENERE
- Autore: CNA Rieti
- •
- 14 set, 2020
Articolo: Vincenza Bufacchi-Direttrice CNA Rieti Quadro: Olio di Laura Federici Moschea ovest 50x150
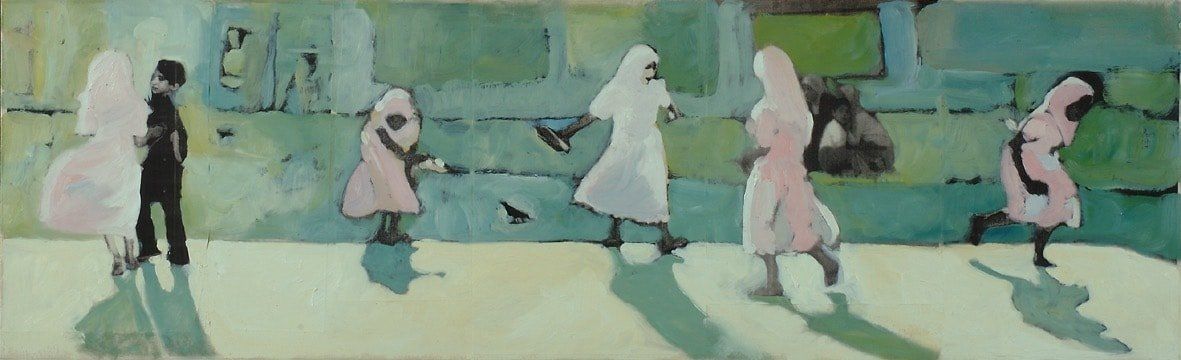
La pandemia e il conseguente lockdown, hanno fatto riemergere un
dibattito su un tema che, in altri tempi, si sarebbe chiamato "questione
femminile".
Cosi ci si è "accorti" con stupore che sulle donne pesa
ancora la maggior parte del lavoro di cura e di educazione della prole,
che le donne lavorano in numero minore degli uomini, ma perdono lavoro
in numero maggiore.
Ora quel che veramente stupisce in questo dibattito è lo stupore!
Ma lo stupore è anche indicatore di quanto in questi ultimi anni il
problema del rapporto tra le donne e l'organizzazione sociale e, più in
generale, il tema della differenza di genere e delle sue implicazioni
economiche, sociali, culturali e valoriali, siano spariti dall'agenda
politica e siano stati appannaggio di pochi addetti ai lavori, per lo
più di addette ai lavori, economiste, filosofe, sociologhe.
Qualcuno
deve aver pensato che in questi anni privi di movimenti femminili e
femministi e delle loro lotte, si fosse compiuto qualche miracolo e che
tutte le contraddizioni si fossero misteriosamente risolte.
Quando
dico assenza di movimenti femminili e femministi penso a quella presenza
organizzata e permanente che, attraverso l'elaborazione prima e
l'iniziativa politica poi, poneva obiettivi e raggiungeva risultati cioè
conquiste sociali, culturali, e non la caratteristica di episodicità di
movimenti, pure encomiabili, come il Me Too.
In realtà in questi
anni non solo nessuna nuova significativa conquista è stata fatta, ma
quel che è più grave è l'arretramento culturale anche su elementari
acquisizioni che sembravano ormai patrimonio condiviso si è tornati così
a trattare i problemi che riguardano la presenza delle donne nella
società come i problemi di una minoranza, dimenticando che le donne non
sono na minoranza e che la differenza di genere è la differenza delle
differenze, quella che si riproduce in qualsiasi classificazione, in
qualsiasi ambito.
Non c'è bisogno di molti esempi per capire questo
elementare concetto: i giovani sono, uomini e donne, i diversamente
abili sono uomini e donne, qualsiasi minoranza etnica è formata da
uomini e donne.
Ho citato questo esempio perché è forse il più eclatante.
Ma perché è successo tutto questo?
Credo che l'azione dei movimenti femminili e femministi e quindi anche
la loro capacità di dettare l'agenda politica ai partiti e alle
istituzioni, si sia esaurita nel momento in cui l'obiettivo per il quale
lottare non era più chiaramente individuato nella conquista di un
diritto, quale atto di riparazione di una disuguaglianza formalmente
sancita dall'ordinamento giuridico.
Negli anni '70, '80 e '90 gli
obiettivi dell'iniziativa politica erano chiaramente individuati, basta
scorrere l'elenco delle numerosissime leggi promulgate in quegli anni,
pietre miliari prima nel percorso di emancipazione delle donne e poi di
valorizzazione della differenza di genere.
Questo lungo processo
iniziato nel 1919 con l'abolizione della tutela maritale, si conclude
nel 1996, quando viene approvata la legge sulla violenza sessuale che
iscrive il reato tra quelli contro la persona e non più tra quelli
contro la moralità e il buon costume.
Tra queste due date il
suffragio universale del 1946 e le leggi degli anni '70, il nuovo
diritto di famiglia, la legge di parità di trattamento, quella
sull'interruzione di gravidanza, solo per citarne alcune perché l'elenco
sarebbe lunghissimo.
Sembra che la lotta per queste conquiste abbia
fiaccato le donne dei movimenti e dei partiti, forse hanno pensato che
l'aver affidato all'ordinamento giuridico le conquiste, fosse
sufficiente a produrre i mutamenti sociali e culturali che in parte le
leggi registravano, perché già maturate nella coscienza civile, in parte
promuovevano.
Cosi non è stato e, come in tutti i fenomeni che
hanno a che fare con la vita, là dove non si producono passi in avanti,
si producono arretramenti.
Che cosa si può o si deve fare ?
La mia idea è che per andare avanti bisogna tornare indietro e riprendere il compito dal punto in cui si era interrotto.
Bisogna tornare a elaborare, organizzare, produrre iniziative, bisogna cioè tornare all'agire politico.
Bisogna ricominciare a lottare per tutte quelle conquiste sociali che
riguardano tutti, ma che impattano maggiormente sulla vita delle donne
perché per lo più o esclusivamente sono loro a subire le conseguenze dei
mancati mutamenti sociali.
Ma oltre a questo e forse prima di
questo c'è da svolgere un compito più difficile perché bisogna
organizzare azioni che abbiano come obiettivo il cambiamento
dell'immaginario collettivo, cioè un cambiamento culturale e ravvisare
nel mutamento perseguito un orizzonte di senso.
L'esperienza mostra che molto spesso le leggi non bastano se non si cambia l'universo simbolico.
Chi impedisce oggi alle giovani di frequentare le facoltà scientifiche?
Nulla, se non stereotipi ancora largamente diffusi che prevedono ruoli
maschili e femminili cristallizzati, addirittura pregiudizi sulle
capacità delle donne e altre analoghe aberrazioni.
Un potente alleato di questa percezione del mondo è il linguaggio.
Fino a quando il genere femminile sarà usato per definire ciò che è
riferito a una donna, non sarà possibile la costruzione di un
immaginario collettivo che riconosca che il mondo è popolato da due
sessi.
Fino a quando le donne non saranno nominate, non saranno!
"Nomina sunt consequentia rerum" scriveva Giustiniano nelle Istituzioni,
per dire che prima ci sono le cose e poi le si nomina, e
conseguentemente che finché non le si nomina non ci sono.
Nessuno
forse ha espresso meglio questo concetto di come abbia fatto
Wittgenstein, il grande filosofo del linguaggio, quando dice: "I limiti
del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo".
Per l'uso del
genere femminile nella lingua italiana ci sono anche le regole scritte
da due grammatici addirittura di fine '800.
Ora ci sono le donne in
tutti i mestieri e i ruoli e ci sono le regole per nominarle: le
fornaie, le direttrici, le sindache, le prefette.
Perciò non possono
più trovare legittimazione le espressioni "voglio essere chiamata", o
"suona male", per perpetuare un uso sessista della lingua italiana.
Quanto alla prima espressione bisogna replicare che ci sono le regole e
non le preferenze individuali, quanto alla seconda che ci sono tante
parole che suonano male ma non per questo non le usiamo, e che,
comunque, usandole perderanno questa caratteristica. Quanto dovette
suonare male la parola maestra quando la si cominciò ad usare per
indicare un "maestro" donna? Eppure oggi che questo lavoro si è molto
femminilizzato, quasi "suona male" il maschile maestro.
Le parole
declinate al femminile devono costituire il lessico della costruzione di
un universo simbolico che preluda alla piena e completa espressione
delle donne.
La specie umana è l'unica specie che è diventato genere
e proprio questa caratteristica ha prodotto il patrimonio di bellezza
fatta di scoperte scientifiche, opere artistiche, letterarie,
filosofiche, musicali.
Non si è riflettuto a sufficienza sul
nocumento arrecato, prima alle donne, e poi a tutto il genere umano, per
aver impedito loro di sprimere compiutamente la loro appartenenza al
genere umano.
Celebriamo le creazioni di tanti pittori, scultori,
musicisti, poeti, filosofi, scienziati, ma un così esiguo numero di
opere di pittrici, scultrici, petesse, filosofe, scienziate, perfino di
Sante, da avere la immediata percezione di che cosa l'umanità abbia
perso!
Quanto ancora dovrà continuare? Quanto ancora l'umanità dovrà perdere?
Queste domande interrogano innanzitutto le donne, ma non solo le donne.
Vincenza Bufacchi
Olio di Laura Federici
Moschea ovest 50x150
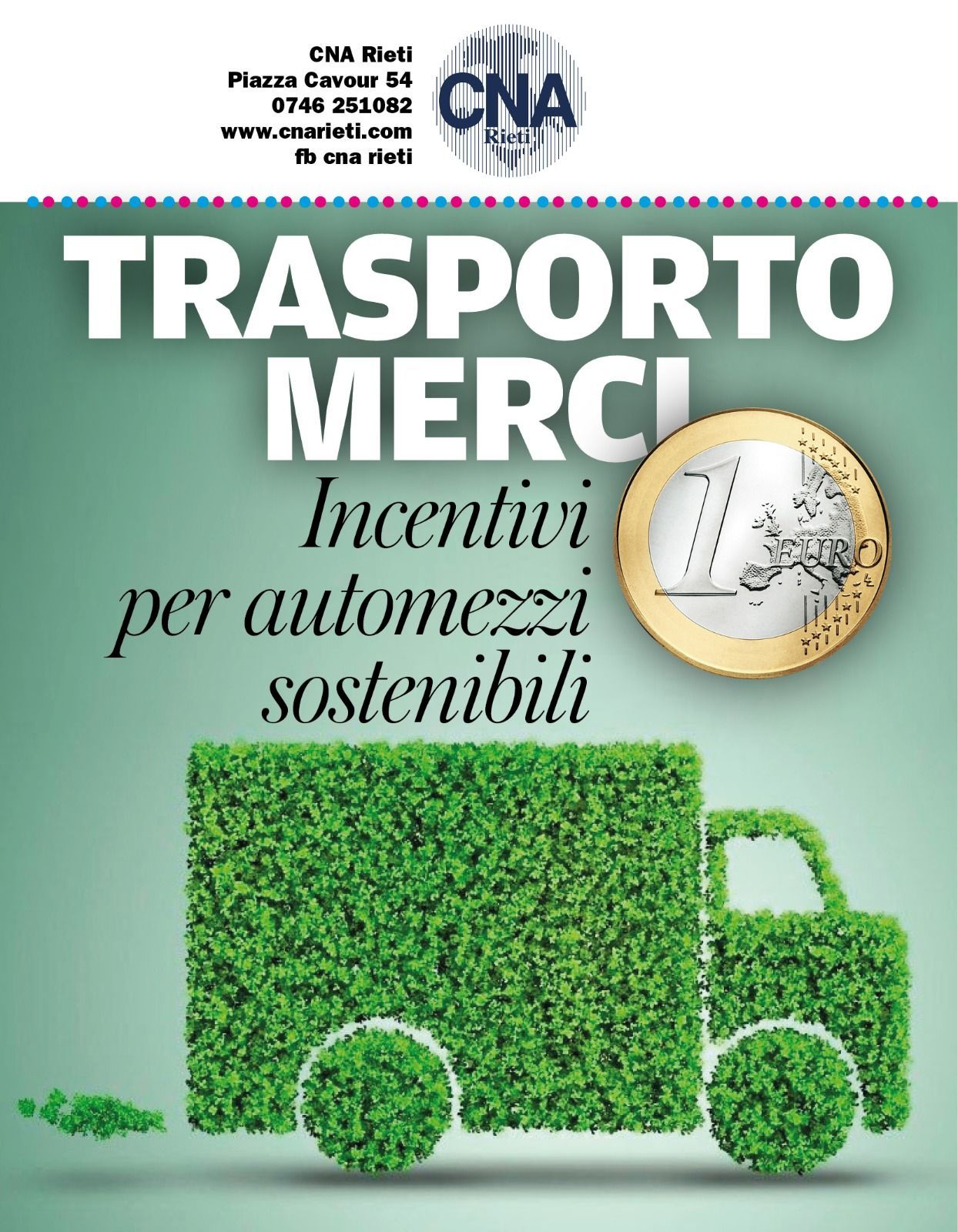

Tel. 0746251082

clienti o, ancora, ai requisiti richiesti dai bandi per la partecipazione a gare d'appalto o a bandi per ottenere incentivi.
Alcuni esempi di certificazioni:
Per informazioni o prenotare un appuntamento: